
Eventi in Corte
La Corte dialoga. Convegni, seminari, incontri su diverse tematiche, che si tengono presso il Palazzo della Consulta. Spunti di riflessione, occasioni di dibattito e di scambio che, di volta in volta, coinvolgono anche alcuni membri del Collegio della Corte.
I cento anni del Presidente emerito Cesare Ruperto

Nel Salone Belvedere di Palazzo della Consulta si è tenuta una cerimonia in onore dei cento anni
del Presidente emerito Cesare Ruperto. Alla cerimonia hanno preso la parola il Presidente della
Corte Giovanni Amoroso e la giudice Maria Rosaria San Giorgio, seguiti dal Professore Achille De
Nitto, già assistente di studio del Presidente Ruperto, che ne ha tratteggiato un
ritratto.
La cerimonia si è conclusa con i calorosi auguri del Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, che ha reso omaggio alla straordinaria figura del Presidente emerito e al suo
contributo fondamentale alla giustizia costituzionale italiana.
Il video racconto
L'evento



Il ritratto del Presidente emerito Cesare Ruperto
Achille de Nitto Come un ritratto [per Cesare Ruperto, Palazzo della Consulta, 28 maggio 2025]
Un ritratto contiene, per definizione, la rinuncia all’oggettività, propone immagini irrimediabilmente asimmetriche. Fuori dal paradigma della neutralità e dell’esattezza – prerogative, se mai, della fotografia o della biografia – aspira, tutt’al più, alla verosimiglianza. La fedeltà dell’interprete è garantita solo dalla fiducia, l’opposto dell’obbligo: condizionata, fecondata, dal sentimento o dall’empatia. Nel caso, dall’affetto. Il ritratto considera l’uomo del momento: compendia per approssimazione e valorizza l’eccedenza. Raccoglie non già le precise memorie di fatti o atti di una vita, ma, se mai, i loro esiti, i frutti delle innumerevoli esperienze. Nel presente è come rintracciasse le impronte del passato, fino al tempo delle origini, come nella storia di un albero i cerchi concentrici del tronco: cronologie all’incontrario, la freccia del tempo perturbata dai lampi illuminanti del ricordo. Gli sguardi, le rughe, le posture, i gesti, le espressioni, la voce, i toni, l’inflessione, il sorriso, lasciano scommettere sulle costanti, come pure sulle prevalenze o le discontinuità. Nei documenti, invece, nelle carte, restano depositati con accuratezza evenienze per lo più curricolari.
La nascita ufficiale, proprio oggi, di questa raccolta di Studi – settecento pagine, sessanta autori – consente di deviare, per un attimo, l’attenzione dall’occasione che l’ha generata: con ciò preservando, in qualche modo, una certa refrattarietà del presidente Ruperto – autore, peraltro, di diversi scritti sul tema dell’età – per le ricorrenze e le celebrazioni che direttamente lo riguardino. Resta, in ogni caso, un evento straordinario e, in questo palazzo, assolutamente senza precedenti, che raccoglie intorno a lui – a Saverio e a Valeria – tante e tante persone, nel clima affettuosamente discreto della gratitudine e del ringraziamento, oltre che dell’ammirazione e della testimonianza.
Nella benevola severità del presidente, nella costanza delle sue maniere – nella sua inconfondibile gestualità –, l’autorevolezza non è scalfita dall’affabilità, né la riservatezza dalla sincerità. Il rigore, del resto, non interrompe i flussi della generosità. E nel “giudice emerito” – il richiamo alla lettera del regolamento sembrò, a suo tempo, quasi una civetteria – si condensano, con persistenti risonanze della medesima vocazione alla giustizia, le figure di quel giudice che lo hanno preceduto, del pretore, soprattutto: il pretore di Sezze (che, quasi cinquant’anni dopo, gli darà la cittadinanza onoraria) e il pretore e giudice tutelare di Genova, la sua prima sede. Nel giudice delle leggi, troviamo il giudice che ha applicato le leggi; nel componente dell’organo di garanzia della Repubblica, il giudice che ha amministrato la legalità dello Stato, fino alla nomofilachia; nel giudice del giudizio incidentale “senza parti”, il propugnatore della concezione pubblicistica del processo civile, contro quella agonistica del giudizio; nel maturo testimone della fede nella giuris-dizione, il giovane cultore della legis-dizione. Si avverte lo stile collaudato di decenni di aule di giustizia: udienze governate con polso fermo, ma dialogante; studio accurato, ma essenziale, dei fascicoli, sentenze asciutte, senza sbavature. E poi l’appassionato impegno degli studi: rassegne di giurisprudenza, repertori, codici commentati, saggi, voci enciclopediche, note a sentenza. Il peso degli insegnamenti ricevuti: nella frequentazione di tanti studiosi, civilisti e non (a Genova, ad esempio, Satta e Orestano e, a Roma, Betti e Ascarelli) e nella consuetudine, anche in sodalizi editoriali, con tantissimi, non solo colleghi (Gabriele Pescatore o Andrea Torrente, in primis, e Mario Berri, nella Nuova rassegna, erede di quella di Nicolò e Stella Richter). Il debito riconosciuto verso i maestri, alcuni maestri: Ubaldo Boccia, nell’ars iudicandi, già nell’uditorato del ’50 (lo stesso concorso – tra i primi in graduatoria – di Franco Piga, Antonio La Torre, Riccardo Chieppa, Vittorio Sgroi, Aldo Corasaniti, Renato Granata, Filippo Mancuso); alla Sapienza – dopo Filippo Vassalli – Fulvio Maroi (laurea, luglio 1948, e un breve assistentato), l’impronta di Roberto de Ruggiero e, alle spalle di tutti, quella ancora così influente di Scialoja. E, prima, l’esordio alla “scuola messinese” (preside sempre Pugliatti) e, prima ancora, a Nicastro, don Luigino Costanzo, professore nel liceo “Francesco Fiorentino” (l’allievo di Galluppi, giobertiano, hegeliano, poi legato agli Spaventa). E il padre, Saverio, il giudice conciliatore, sentenze mai appellate, tranne una (sarà stata sbagliata – disse con rispetto – forse la legge); e l’infanzia, il dolore per la giovanissima mamma perduta, le sorelle, la vecchia nutrice. Se le emozioni non hanno, ma sono, la loro memoria, l’esperienza della Corte, del resto, dopo oltre un ventennio dalla fine del mandato, sembra, per tanti versi, ancora attuale: nell’intramontabile prossimità spirituale con tanti colleghi del collegio dei nove anni (una traccia, tra le altre, nell’indice del volume: «il mio vicino di banco in camera di consiglio»), ciascuno con un posto particolare, qualcuno di più. E se si fa torto a non fare i nomi di tutti, non è azzardato immaginare che la colleganza idealmente si estenda – come, del resto, qui appare palese – a tanti predecessori e successori.
Una tempra geneticamente segnata dal kairós: la misura, il punto giusto, il conveniente, l’opportuno, il fair; ciò che si addice, che risulta appropriato, acconcio, adeguato, adatto. Tempi, modi, strumenti, argomenti, soluzioni giuste. Persone giuste, nel senso della giustezza, non solo della giustizia. La precisione dell’intuito, se non dell’ispirazione, piuttosto che quella del calcolo: la propensione ponderata più alla scommessa, che non al conteggio. L’attitudine a discernere, anche fulmineamente, e a deliberare: a valutare le condizioni dell’azione e i suoi contesti. La virtù di stare dentro gli eventi governandone l’impeto, per quanto si può. Si può sbagliare, ma non per mancanza di coraggio. L’innata maestrìa nell’arte del comando: nessun ordine espresso, tutti eseguono spontaneamente, riconosciuti, però, a uno a uno. Si potrebbe dire in un altro modo. La capacità di stare al passo con la propria giornata, la vita intera; contemporanei di sé stessi, una storicità esistenziale, nessuna teoria della storia. Niente nostalgie, solo ricordi; niente velleitarismi, ma nessuna rinuncia alle proprie idealità. Non il pragmatismo del carpe diem, inseguire l’attimo prima che fugga. Piuttosto il realismo di chi sa accelerare o rallentare quanto basta, con rapidità, ma senza fretta. Il paradosso del festìna lente, se hai fretta, vai piano; se hai tempo, non perdere tempo. Dopo i lunghi lavori di restauro della sala d’udienza (la “sala gialla”, dall’oro dei suoi damaschi), il crocifisso – forse accidentalmente lesionato – non fu rimesso alla parete, dove probabilmente si trovava già con la presidenza de Nicola, venendo sostituito con una Sacra Famiglia di Perin del Vaga. Un’immagine, non un simbolo. Qualche mugugno, anche pungente, clamori polemici sulla stampa; ma al presidente, cattolico convinto e praticante, parve un’occasione propizia, a un anno, peraltro, dalla pronuncia sull’illegittimità del vilipendio della religione di Stato. O le prese di posizione – sempre esplicite ed energiche, anche quando riservate – a proposito, ad esempio, della mancata citazione del presidente della Corte – una svista nel protocollo – tra le autorità presenti a Montecitorio per la storica visita del Santo Padre (un assente, così, non può applaudire); o a proposito della «grave inadempienza costituzionale» del Parlamento nella mancata elezione, dopo quindici mesi, di due giudici costituzionali; o ancora, delle paventate iniziative in tema di devolution; o del dovere di esprimere il proprio voto nel referendum confermativo. E così via.
Inclinazione alla focalità, qui ed ora: mettere a fuoco e selezionare l’elemento decisivo del contesto, sotto la guida dell’intelletto pratico, la frónesis, la prudenza, non solo la scienza. La visione, ma anche la pre-visione di ciò che riguarda, anche nei dettagli, gli uomini di questo mondo. Una razionalità consapevole dei propri limiti, dotata di antidoti contro l’abuso, della logica anzitutto, e contro le fallacie del ragionamento. La leggerezza che sa sottrarre peso all’esistente, liberandolo dalle ridondanti rigidità. Novembre 2001. Giusto a ridosso della riforma del titolo V, il presidente, accettando l’invito a un convegno nell’Università di Trento (per iniziativa di un’associazione di studenti), promosse un viaggio della Corte (per la prima volta, insieme in treno, con altri sei giudici) e poi a Bolzano, nella sede della Provincia. Fu la prima di una serie di iniziative che lo portarono, via via, a Palermo, Aosta, Trieste e, tra le altre Università, Roma a parte, via via a Bari, Teramo, Milano, Salerno, Lecce. Un itinerario che lo avrebbe peraltro sospinto, secondo le sue non condivise aspirazioni, in qualsiasi luogo del paese dove fosse possibile convocare un’udienza della Corte. La fermezza dei convincimenti appare, tuttavia, predisposta alla scoperta, senza riserve, verso scenari inesplorati, custoditi magari in angoli segreti della mente come accumuli di possibilità. Così, ad esempio, nell’interesse per le pagine più recenti di Paolo Grossi o per quelle più nascoste di Alessandro Giuliani; o per quelle di Nadine Gordimer, nella consegna, palazzo ducale di Genova, di un ulteriore premio («le dimensioni delle cose emergono e prendono lentamente consistenza mediante la parola»: nella letteratura, come processo della scrittura, e nell’esperienza giuridica, come terreno della controversia). Così anche quando, una mattina di giugno – telefonata senza preavviso del prof. Guido Rossi, commissario della FIGC –, il presidente aderisce con disinvoltura, ormai da emerito, all’invito di presiedere l’organo della giustizia sportiva per i problemi di “calciopoli”, nell’ordinamento che vincola ai doveri di «lealtà, correttezza e probità». O quando accoglie la visita a palazzo del principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie (l’idea della pluralità degli ordinamenti può esprimersi, in concreto, anche così). O quando, per anni, è assiduo nelle innumerevoli iniziative di quello straordinario laboratorio che era il Club dei giuristi all’Istituto Sturzo. Nella stessa ottica, del resto, di indipendenza e di lealtà (amicus Plato) – con un profilo da combattente (o «da condottiero», come in una affettuosa pagina della signora Franca) per una causa reputata giusta –, può collocarsi, tra i tanti, l’episodio che segue. Nell’aprile del ‘55, la Cassazione penale cassa una sentenza del Pretore di Sezze in materia di sanzioni applicabili alla panificazione casalinga per la vendita in pubblici esercizi: la condotta – riferita a una dozzina di anziane signore del paese – integra gli estremi solo di una contravvenzione e non il reato previsto da una legge del 1949 sulla disciplina delle relative industrie. Contrastando quell’arresto, l’autore – poco più che trentenne – di una nota sul Foro del ’56 non esita a rivolgere, senza giri di parole, garbate ma pesanti critiche: l’«autorevole Collegio» avrebbe proceduto a «un esame della legge troppo rapido e incompleto per non giustificare gravi perplessità nello studioso e in genere nel lettore attento, il quale difficilmente si convince che al giorno d’oggi sia lecito procedere in alcun modo alla produzione, senza licenza, di pane destinato alla vendita al pubblico». Il coraggio e la fierezza – o la temerarietà – di questo atteggiamento appaiono addirittura accresciuti dalla circostanza che la sentenza cassata fosse opera del suo ufficio, per quanto sottoscritta dal predecessore. Allo spirito dell’innovatore appartengono, del resto, sia la proposta, pressoché inascoltata, di introdurre, nel giudizio costituzionale, l’opinione dissenziente, contro unanimismi solo di facciata e a favore dell’effettiva collegialità; sia l’introduzione della consuetudine di chiudere le camere di consiglio, sempre e comunque, tutti i giudici con una stretta di mano; sia, nel 2002, la modifica, per praticità, della norma regolamentare sulla composizione dell’ufficio di presidenza (non più sei giudici, come era dal ’58, ma tre). Sia, ancora, la decisione di dotare la Corte di un ufficio del portavoce del presidente, affidandolo a un giornalista professionista (comunicati stampa sulle pronunce solo un minuto dopo il deposito); o l’idea e la realizzazione a più mani, su una bozza predisposta dal giudice Onida, del volumetto divulgativo sulla Corte, destinato soprattutto ai giovani (e solennemente presentato proprio nel salone del Belvedere alla presenza di 130 studenti di sei istituti scolastici di diverse parti d’Italia, buffet finale preparato da alcuni di loro).
«Calabrese di nascita e di temperamento», parole sue. Una terra nel cuore, ma certamente anche un cuore nella madre terra. La sacralità di legami indissolubili nel profondo, non già quei vincoli ufficiali di mera appartenenza (conferenza nella Sala del Cenacolo, ottobre 2001: come risuonasse l’eco delle acque dell’Angitola nella devota ammirazione, due secoli dopo, per il vescovo Serrao, martire della rivoluzione napoletana del ’99 e fondatore di Filadelfia, la nuova Castelmonardo, distrutta dal terremoto del 1783). Modi condivisi di sentire, di concepire e rappresentare uomini e cose: mentalità, linguaggi, abitudini, atteggiamenti, perfino gusti, percepiti come comuni. Impronte indelebili nelle storie delle persone, nelle cadenze, nelle inflessioni, vissute con orgoglio, senza vanterie. Senso dell’amicizia, dell’ospitalità, dell’accoglienza, ma del rispetto, dell’onore, del riserbo, della dignità: nessun equivoco né confusione anche di ruoli, la chiarezza di un’autenticità senza filtri. Le identità personali, o quelle locali o quelle comunitarie, concepite come frontiere, varchi aperti per congiungerle: fuori dall’angustia di chiusi microcosmi o soffocanti ragnatele, mondi naturalmente comunicanti ed esposti alla contaminazione e al contagio. L’atmosfera del lavoro nella segreteria del giudice e poi nel “Gabinetto” del presidente – un’altra apparente civetteria – richiamava, con un’immagine coniata da lui stesso, il fervore di una «bottega rinascimentale»: oltre le competenze, i talenti, valorizzati quasi senza volere, ciascuno coinvolto nell’opera di tutti. Uno stile di condivisione, anche nel dissenso, quella «letizia» – parola sua – sviluppata dalla fiducia o direttamente dalla simpatia. Ed estesa senza fatica ai sopravvenuti o ai tanti, nei diversi uffici, di collaborazione anche meno diretta (ma gli uomini della scorta premurosi anche nelle chilometriche passeggiate a passo veloce).
Quel giudice e quel giurista, educati al culto della soggezione alla legge e della certezza del diritto legale, hanno, tuttavia, resistito a più di una lusinga: a quella, da un lato, del puro formalismo, del concettualismo o del dogmatismo, fatalmente esposti, nelle diverse forme, ad esiti di segno assolutistico o nichilistico; dall’altro lato, a quelle dell’uso “politico” della giustizia, considerato che l’«assoluta irresponsabilità» del giudice, «necessariamente conseguenziale alla sua piena indipendenza interna ed esterna, è incompatibile col potere di partecipazione alle scelte politiche del Paese», spettanti a Parlamento, Governo, partiti e sindacati. Alla base, da un lato, un’istintiva avversione verso astrattezze, astruserie o accademismi; dall’altro, un irrinunciabile costume di moderazione e di responsabilità (che, se non fosse eccessivo, si dovrebbe chiamare semplicemente onestà). E mentre imperversa la violenza degli anni di piombo, in un Paese sconvolto dalla lotta «contro le istituzioni democratiche», il presidente dell’UMI considera non più rinviabile, la ricostituzione – senza abiure, dopo vent’anni di fratture – dell’unità associativa all’interno dell’ANM.
Nella molteplice complessità dello Stato costituzionale, la Costituzione si disvela – a chi si dichiara affrancato «da quel positivismo legalistico al quale per mestiere ero rimasto lungamente soggetto» – oltre che come la legge scritta fondamentale, anche come quell’immenso e indisponibile patrimonio di umanità e di civiltà iscritto nel tessuto più profondo della coscienza collettiva: La Costituzione in mezzo a noi. Ne deriva che la politica, pur legittimata dal consenso, non è l’onnipotente “padrona” del diritto, anche perché i princìpi non hanno padrone; che il diritto non è un semplice prodotto della legge o solo delle regole scritte o procedurali; che la conoscenza giuridica, in quanto connessa ad esperienze valutative, riguarda, oltre la tecnica, la cultura. E ancora: che alla inesausta ricerca della migliore qualità dello stare insieme, partecipano una pluralità di attori, ciascuno nel suo ordine di competenza; che, attraverso la “giustizia” costituzionale, la legislazione, in qualche modo, si “giurisdizionalizza”; che nei giudizi di legittimità costituzionale si valuta, ex bono et aequo, in termini di compatibilità, più che solo di conformità. Senza che tutto ciò minimamente implichi né il rinvio a un fantomatico diritto di natura, né l’affermazione di un improbabile primato dei giudici. Dalla legge al diritto appare, perciò, molto più del titolo di un’antologia: è la testimonianza di un lungo itinerario di applicazione e di interpretazione, di ponderazione e di intuizione, di ragione e di passione. Di un uomo – non di un eroe – che nella «tremenda responsabilità del giudizio», ha saputo vivere, serenamente e senza struggimenti, «il travaglio della necessaria umiltà pur nell’esercizio integrale dell’autorità». Grazie, presidente!
In memoria di Aldo Mazzini Sandulli (1915-1984) - 12 dicembre 2024
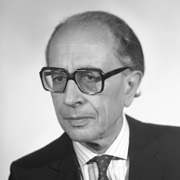
Il 12 dicembre 2024 nel “Salone Belvedere” del Palazzo della Consulta si è svolto l’incontro di
studio in memoria di Aldo Mazzini Sandulli (1915 – 1984), promosso dal Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli studi Roma Tre con il patrocinio della Corte
costituzionale. Al centro della giornata, la rilettura della parte dedicata ai presupposti
processuali e alle condizioni dell’azione del volume “Il giudizio davanti al Consiglio di Stato
e ai giudici sottordinati”, Napoli, Morano editore, 1963.
La giornata ha avuto inizio con i saluti del Presidente della Corte costituzionale Augusto
Antonio Barbera, seguiti dagli interventi del Rettore dell’Università degli Studi Roma Tre,
Massimiliano Fiorucci, e dal Presidente del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti.
Successivamente ha moderato e coordinato l’incontro il Giudice costituzionale Filippo Patroni
Griffi. Sono intervenuti Vittorio Domenichelli, Ordinario di Diritto amministrativo presso
l’Università degli Studi di Padova e Antonio Cassatella, Associato di Diritto amministrativo
presso l’Università degli Studi di Trento.
La giornata si è poi conclusa con un intervento del Presidente di sezione del Consiglio di
Stato, Francesco Caringella.
Incontro di Studio in memoria di Aldo Mazzini Sandulli - Saluti istituzionali
Incontro di studio in memoria di A.M. Sandulli - Intro Pres. F. Patroni Griffi e Intervento Prof. V. Domenichelli
Incontro di Studio in memoria di Aldo Mazzini Sandulli – Intervento Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli
Incontro di Studio in memoria di Aldo Mazzini Sandulli - Intervento Cons. Francesco Caringella
Incontro di studio in memoria di Aldo Mazzini Sandulli - II giornata
Verso la parità formale e sostanziale – 10 maggio 2024

Il seminario "Verso la parità formale e sostanziale", promosso dalla Rete per la parità con il patrocinio della Corte costituzionale, si è tenuto il 10 maggio 2024 nella Sala Conferenze di Palazzo della Consulta. Un bilancio a 64 anni dalla sentenza della Corte costituzionale che aprì le porte alle donne nelle carriere pubbliche. È intervenuto per i saluti iniziali il Presidente della Corte Augusto Barbera, seguito dalla Presidente della Rete Patrizia De Michelis. Hanno poi preso la parola le relatrici: la Giudice costituzionale Emanuela Navarretta; Linda Laura Sabbadini, già Direttrice ISTAT, Chair W20; Serena Lippi, Presidente Associazione Donne Italiane Diplomatiche e Dirigenti, Consigliere diplomatico presso il MIM; Rosa Vinciguerra, Tenente Colonnello dell’Esercito, e l’atleta Alice Pignagnoli. Simona Rossitto ha infine intervistato Rosa Oliva, Presidente onoraria della “Rete per la parità”, e Gabriella Luccioli, già Presidente di sezione della Corte di cassazione. All’incontro sono intervenuti i Giudici costituzionali Luca Antonini, Marco D’Alberti, Stefano Petitti e Maria Rosaria San Giorgio. Ha coordinato il seminario il Vice Direttore di Repubblica Francesco Bei.
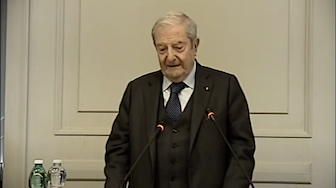

Modera: Francesco Bei

La Corte costituzionale per i diritti delle donne

Accelerare il cambiamento: le sfide per rompere le resistenze

Le ambasciatrici: mission impossible?

La lunga marcia delle donne nella Difesa



































































